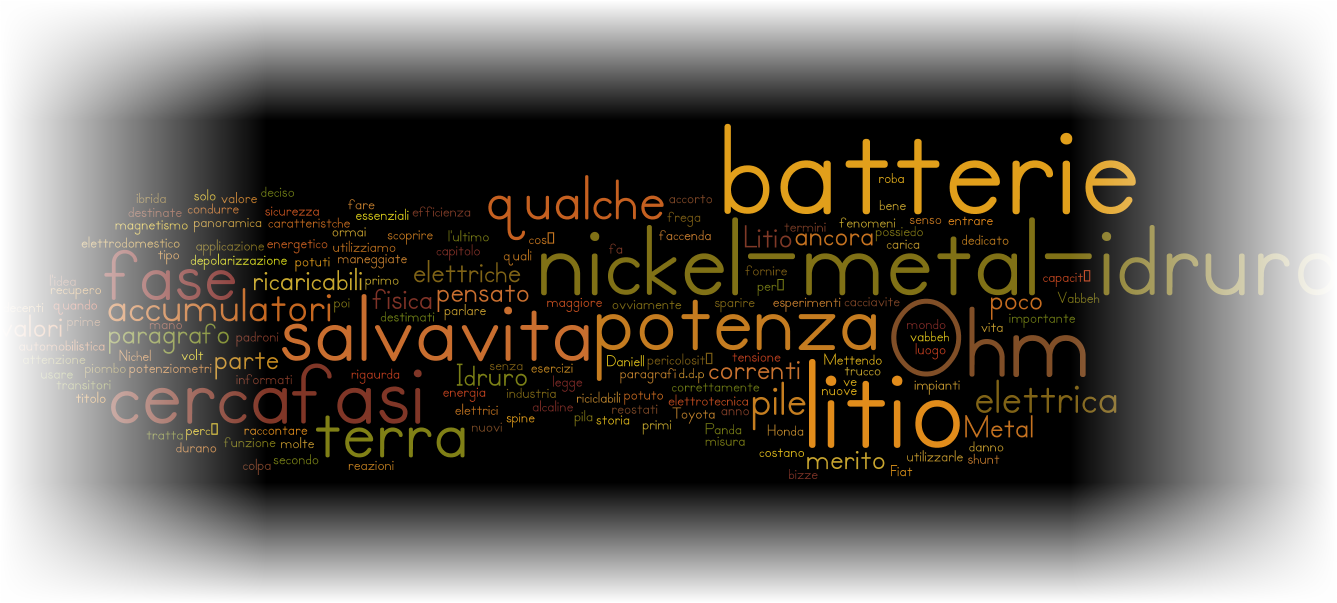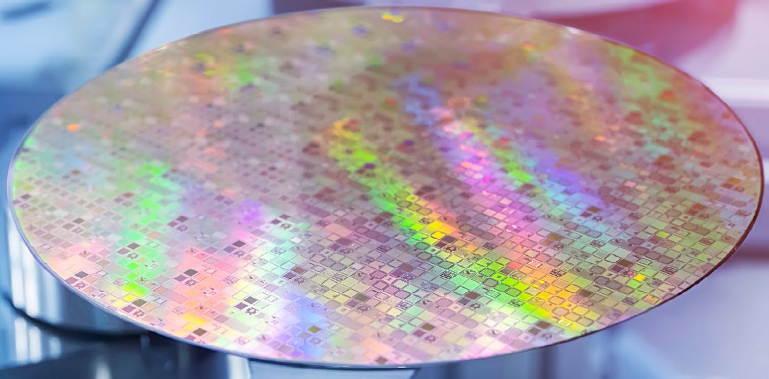ma il magnetismo esiste o ha bisogno delle correnti?

C’è una novità che scatta da questo post; i capitoli del corso di fisica contengono una introduzione leggibile anche da chi non entrerà nel merito. E la introduzione uscirà sul mio sito man mano che procedo alle revisioni. Ecco la prima.
Lo scopo di questo capitolo è quello di introdurre la grandezza fondamentale che riguarda i fenomeni magnetici e cioè il vettore induzione magnetica .
Il capitolo si apre con una introduzione di carattere storico-fenomenologica come è nella impostazione di questo corso. La parte di tipo fenomenologica riassume i semplici esperimenti (pratici e/o mentali) che, partendo dalla esistenza dei magneti naturali consentono di arrivare a parlare di poli magnetici e di stabilirne nomenclatura e caratteristiche.
E’ bene sapere che il magnetismo, in origine, è stato studiato come un fenomeno a sé stante e dunque a fine 700 è stata enunciata una legge basata sull’inverso quadrato della distanza in cui comparivano le masse magnetiche e una costante universale (la permeabilità magnetica) che giocava il ruolo della costante dielettrica e. Quando iniziai a studiare la fisica (negli anni 60 del XX secolo) molti testi continuavano ad introdurre il magnetismo attraverso la legge di Coulomb magnetica.
E’ solo a inizio 800 che, osservando le interazioni tra correnti elettriche, che se ne studiano le reciprocità e si arriva a studiare il magnetismo come effetto di correnti elettriche o di cariche in moto. Nel primo paragrafo trovate la genesi e cenni all’epilogo.
Nel secondo paragrafo e terzo vengono descritti i fatti sperimentali che consentono di arrivare alla definizione del vettore B e contestualmente dare la legge che descrive la forza magnetica. La definizione non è semplice da digerire perché il campo magnetico presenta problematiche complicate di orientamento e sul piano delle complicazioni matematiche richiede la introduzione del prodotto vettoriale.
Si definisce la unità di misura, una unità dimensionata malamente perché raramente si hanno campi magnetici dell’ordine del Tesla, ma trattandosi di una grandezza derivata è tutta colpa della definizione dell’unità di corrente. Per altro, con lo sviluppo dei superconduttori, e dell’uso che se ne fa nelle apparecchiature di risonanza magnetica, disponiamo finalmente di campi magnetici in aria dell’ordine del Tesla.
Il quarto paragrafo introduce le due leggi fondamentali dell’elettromagnetismo che consentono, dato un sistema di correnti elettriche, di determinare punto per punto nello spazio il valore del vettore induzione magnetica. Si tratta di due leggi strutturalmente diverse: la prima ha natura integrale e descrive una proprietà complessiva (nello spazio) del campo magnetico; la seconda ha invece natura differenziale e ci dice, in ogni punto dello spazio quale sia il contributo dato al campo magnetico da ogni piccolo elemento di corrente elettrica.
Come si dimostrano? Non si dimostrano; sono vere e basta e, come molte leggi generali della fisica altro non sono che nostre astrazioni che consentono di descrivere i fenomeni fisici in forma del tutto generale.
Attraverso queste leggi vengono stabilite quelle che esprimono il campo magnetico generato da configurazioni semplici di correnti elettriche quali le spire circolari o i solenoidi (termine introdotto da Ampere) che esprime un insieme di spire ravvicinate (gli avvolgimenti che fanno da base al funzionamento di quasi tutte le macchine elettriche).
Nel quinto paragrafo compare una nuova grandezza fisica che sembra messa lì tanto per dire: il momento magnetico una grandezza che viene definita per l’ago magnetico e per la spira circolare percorsa da corrente. Ma perché complicarsi la vita?
La risposta sta nel fatto che, in fisica atomica e nucleare compaiono proprietà degli atomi e delle particelle elementari che richiedono, per essere descritte, proprio il momento magnetico. Ma c’è di più, per le particelle elementari il momento magnetico è una proprietà intrinseca e non ha bisogno di correnti elettriche. E’ così perché la natura è fatta così. Dunque impariamo a conoscerlo perché ci servirà…
Rispetto alla versione ho completamente eliminato un paragrafo che avevo scritto riscritto più volte e ogni volta che lo rileggevo mi lasciava insoddisfatto: si trattava di descrivere il magnetismo come elemento non sostanziale, ma figlio del campo elettrico in ambito relativistico. Su questo terreno è inutile cercare di divulgare senza introdurre la sostanza (le trasformazioni di Lorentz per il campo elettromagnetico). Non è roba da corsi di fisica generale ed è meglio lasciar perdere.
Il capitolo si chiude con una serie di esercizi di calcolo del campo magnetico utilizzando le due leggi fondamentali. Sono tutti problemi che richiedono l’utilizzo dell’analisi matematica, seppur a livello elementare (in particolare dei rudimenti del calcolo integrale).
Si tratta di problemi molto formativi che ho selezionato con cura dalla miniera di proposte di un testo classico russo (Irodov) che è ancora il testo di riferimento in ambito internazionale. Naturalmente le soluzioni dettagliate sono fatte da me. Consiglio questi problemi (sei in tutto) perché aiutano a strutturare le proprie capacità di problem solving e perché in qualche caso smentiscono le leggi sui solenoidi spesso presentate come vere quando tali non sono.
Il corso di fisica – le news e gli aggiornamenti del corso – il capitolo 0506